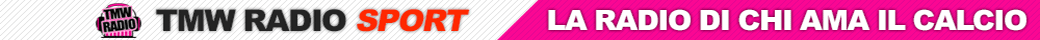Forse non era necessaria alcuna conferma per chi, come chi scrive, considera il calcio attuale del tutto spersonalizzato: la decisione dell’A.S: Roma di non rinnovare a Daniele De Rossi il contratto da calciatore dopo sedici anni, una vita, in giallorosso dice chiaramente che oggi i business plan; i voluntary, settlement agreement; il financial fairplay hanno ormai conquistato l’intera scena. Anche quel cantuccio, sempre più piccolo, destinato a quelle che nel passato si definivano bandiere.
In un certo senso sopravvive Chiellini con la Juventus; per ragioni anagrafiche o di opportunità sono stati giubilati, negli ultimi anni, i Del Piero, i Buffon, i Totti e, appunto, ‘Capitan Futuro’.
E dalle parti nostre Domizzi, Pinzi (oggi richiamato a rinforzare il settore tecnico bianconero), soprattutto Totò Di Natale.
Daniele sembra non volerci stare: alla Roma gli hanno offerto un posto da dirigente, sapendo benissimo che, sebbene a quasi 36 anni, il ragazzo ostiense non intende appendere gli scarpini al classico chiodo dopo oltre 600 gare in maglia giallorossa. Cercherà fortuna altrove: gli States potrebbero offrirgli un approdo sicuro, ma non è escluso che anche in Europa c’è chi potrebbe chiedergli una mano lì, in mezzo al campo dove De Rossi ne ha date, tante, e tante ne ha prese.
Non sìndaco, mai, sulle scelte delle società: ognuno gestisce le proprie risorse, economiche ed umane, come meglio crede. Quello che faccio fatica ad accettare è invece la nonchalance con la quale si cestinano le anime delle squadre, sacrificate sull’altare della competitività.
Non scrivo, lo ammetto, in qualità di esegeta delle qualità del quasi ex-giallorosso: lo faccio, invece, ricordando che altrettanta noncuranza, al netto di un giro di campo (uno) e un mazzo di fiori, sia stata riservata agli eroi di una stagione bianconera.
Esempio? Domizzi. Maurizio ha combattuto, oltre duecento volte, in maglia biancanera considerandola sacra: l’immagine del romano, costernato dopo i due errori contro l’Internazionale in un piovoso pomeriggio, mentre chiede scusa alla curva implorando (ed ovviamente ottenendo!) il perdono della tifoseria è, ancora oggi, assolutamente commovente; è ingrato pensare che qualsiasi giocatore consideri le squadre di levatura ‘minore’ delle tappe di avvicinamento a quelle di vertice. È più corretto ammettere che, per novantanove calcianti che la pensino così, ne esista uno che invece ci tiene. E ci sta male se le cose non funzionano.
Questo mi tiene lontano dal calcio moderno, oltre ovviamente ad un’età che rende i ricordi calcistici appartenenti alla giovanezza assolutamente impagabili: che non si riesca, a livello dirigenziale, a comprendere come i calciatori siano persone. Ognuno con la propria personalità, attaccamento alla causa, pregi e difetti: non faccio preferenze, preferirei non si massificasse genericamente gli appartenenti ad una categoria.
Calciatori. E gli allenatori? Per quanto precari del posto di lavoro, non fanno eccezione. Prendiamone due non a caso; Conte ebbe a dire ‘sono stato juventino, sono juventino e sarò juventino: dovessi però allenare Milan, Inter, Roma diventerei il più acceso sostenitore nerazzurro, rossonero, giallorosso’. Spalletti ha capacità, e lo sappiamo: ma da Udine se n’è andato con un braccio di ferro pur di raggiungere Roma; e nella sua seconda esperienza capitolina ha trattato Francesco Totti come un giocatore qualsiasi, e non con il rango dovuto a chi ha indossato in carriera una sola maglia, in quasi mille occasioni ufficiali, uscendo fra gli applausi dai campi (avversari) più accaniti ma non meritando nemmeno un secondo durante la sua ultima presenza a San Siro.
Chi preferiamo? Chi difende i propri colori oltre ogni ragionevole dubbio o chi, invece, pur mostrando capacità straordinarie fa capire che in fondo ‘del doman non v’è certezza’? Non lo so.
So invece quale calcio preferisco.
Lo ribadisco: il calcio ideale per i manager di oggi prevederebbe stadi vuoti, o quasi. Basta tifosi che vanno in trasferta; basta controlli e tornelli; basta folle che potenzialmente si radunano fuori per contestare se le cose vanno male, osannare se invece vanno bene. Tutti davanti al maxischermo, a farsi spiegare che il calcio è scienza difficile fatto di marcature preventive, di controlli orientati, di triangoli e rombi e non più giuoco fantastico fatto di meravigliose imperfezioni, di gesti tecnici ed atletici fuori da ogni schema, di ragazzi che si menano ed alla fine si abbracciano perché giusto così.
Loro, e le bandiere ammainate. Noi, che rimaniamo con gli occhi sbarrati davanti alla ‘bicicletta’ del Gallo Belotti, che rovescia in rete invece di cercare una giocata più logica.
Loro che descrivono la ‘garra charrua’ a parole: noi, che la ‘garra charrua’ la sentiamo reale; forse siamo patetici, figli di maglioni come pali, di ginocchia devastate dai calci di scarpe della domenica, fino a che veniva buio e delle ‘busse’ di mamma per le macchie di erba sui pantaloni della Upim ‘che poi non vengono più via!’
Ecco perché mi dispiace che il calcio, ma non solo, sia schiavo dei numeri: ormai la noia di alcuni potenti levantini ha trasformato il calciomercato in una dimostrazione di forza muscolare, in cui all’offerta di cinquanta milioni di euro (per me ancora cento miliardi d’antico conio) per un terzino, la risposta è ‘solo cinquanta?’
De Rossi, nel bene e nel male, è uno di noi: un ostiense terrigno, un ossimoro calcistico. Spesso discutibile ma Daniele è così. Prendere o lasciare.
E la Roma, colpevolmente, lascia.
Ma noi no: fino a quando avremo possibilità difenderemo la storia di questo giuoco.
Ripeto, le scelte manageriali delle squadre di oggi non necessariamente sono errate: lo è commuoversi pubblicamente per l’anniversario della tragedia di Superga e poi fregarsene del cuore di chi ama il calcio, di chi quel vecchio calcio ha compulsato attraverso una sola telecamera, forse due, e le interviste a bordocampo prima della gara.
Il nostro calcio. Il mio.
Altre notizie - Primo Piano
Altre notizie
- 10:13 UEB Cividale, Micalich si coccola Redivo: "È il nostro Maradona"
- 09:52 L'ex Udinese Edenilson riparte dal Gremio
- 09:42 Udinese, nuovo look per Brenner: passa alle treccine. Ora servono i gol
- 09:15 Delneri: "Sono friulano e spero l'Udinese si salvi, contro il Verona lo 0-0 non basta"
- 09:11 Apu Udine, Ikangi: "Siamo un po' provati dalle sconfitte ma siamo dove volevamo essere"
- 08:49 Recupero Udinese-Roma, le informazioni sui biglietti
- 08:15 Heurtaux su Silvestri: "Calo generale dell'Udinese, giocherebbe titolare in parecchie squadre di Serie A"
- 08:00 Heurtaux su Pereyra: "Ragazzo d'oro, è fondamentale per questa Udinese"
- 21:59 Recupero Udinese-Roma, la reazione del club giallorosso: “Ingiusta decisione”
- 21:39 UFFICIALE - Udinese-Roma si recupera giovedì 25 aprile
- 19:45 Heurtaux: "L'Udinese è una squadra forte ma adesso si tratta solo di una lotta mentale"
- 19:38 Verona, i convocati di Baroni per l'Udinese: c'è Duda
- 19:08 Verona-Udinese, saranno 1401 tifosi bianconeri nel settore ospiti
- 19:01 UEB Cividale, Micalich: "Vigevano piazza storica, super rapporti! Sarà una bella trasferta"
- 18:51 UEB Cividale, Micalich sulla prossima stagione "Confermeremo più ragazzi possibile"
- 18:40 UEB Cividale, Redivo. "Felice di restare due anni, obiettivo andare in A1"
- 18:20 UEB Cividale, Lucio Redivo rinnova il contratto per due anni
- 17:38 Piccinini: "L'Udinese ha una situazione migliore rispetto alle altre, può salvarsi"
- 17:25 Udinese U15, ultima di campionato con il Venezia decisiva per l'accesso agli ottavi
- 15:30 Udinese, la probabile formazione contro il Verona: scelte obbligate per Cioffi
- 15:20 Verona, la probabile formazione contro l'Udinese: tanti dubbi per Baroni
- 15:04 Udinese, piace il centrocampista Dagasso del Pescara
- 14:51 Udinese, Cioffi: "A 34/35 punti la quota salvezza, con il Verona con coraggio"
- 14:48 Udinese-Roma, in dubbio Lukaku per infortunio: l'esito dei primi accertamenti
- 14:46 Cantù, coach Cagnardi: "Udine è una squadra che può ambire a vincere"
- 14:42 UEB Cividale, Mastellari: "Con Vigevano atmosfera già da playoff"
- 14:25 UEB Cividale, Pillastrini: “Vogliamo evitare il momento di rilassamento”
- 14:15 APU Udine, Gerosa: "Obiettivo i due punti e strappare il secondo posto"
- 13:15 Udinese, lesione muscolare per Lautaro Giannetti: il comunicato
- 13:10 Roma, lettera alla Lega Serie A: obiettivo posticipare il recupero con l'Udinese
- 12:47 Hellas Verona, Baroni in conferenza stampa: "Duda recuperato, Udinese squadra forte"
- 12:09 Udinese, Perez prossimo alle 100 presenze nei top 5 campionati europei
- 11:57 Udinese, Magda Pozzo: "Il fiore all'occhiello dell'innovazione è il Bluenergy Stadium"
- 10:52 Udinese, il programma della vigilia: rifinitura e partenza per Verona
- 10:44 Udinese, gli impegni del settore giovanile nel weekend
- 10:34 Udinese, sabato può arrivare la 100esima rete contro il Verona
- 08:00 Serie D verso il rush finale, i calendari di Cjarlins Muzane e Chions
- 07:13 Tabellone playoff Primavera 2, il programma: i possibili accoppiamenti
- 07:00 Udinese Primavera, la classifica della lotta playoff e i calendari a confronto
- 23:08 Roma, Ndicka festeggia con i compagni sotto la curva dopo il successo sul Milan
- 22:35 La curva della Roma a Maignan: “ A Udine razzismo, a Milano diverbi”
- 20:05 Apu Udine, infortunio Clark: come sta l'americano? Il punto sulle condizioni
- 20:00 Apu Udine, infortunio Caroti: verso il forfait anche contro Cantù
- 19:51 De Giorgis: "L'Udinese è in difficoltà e spero ce la faccia a salvarsi"
- 19:45 (VIDEO) It's Apu Time, ospite Matteo De Monte: la puntata integrale
- 19:00 Udinese, che partita vuoi fare contro il Verona?
- 18:51 Verona-Udinese, si va verso il sold out: più di mille i tifosi bianconeri
- 17:03 Udinese, si va verso il recupero di Davis per il Verona
- 16:51 Udinese, Brenner completamente recuperato: a Verona arma in più?
- 16:45 Hellas Verona, in dubbio la presenza di Duda per l'Udinese